Informazioni
Indirizzo: SP 65 - 09036 Guspini
Il contesto ambientale
Il sito archeologico di Santa Maria di Nabui è situato a circa 20 km a Nord di Guspini, lungo la strada che porta alla località balneare di Torre dei Corsari, attraverso il centro abitato di Sant'Antonio di Santadi. È ubicato in una stretta pianura alluvionale, delimitata a Sud da un'area collinare a Nord dallo stagno di Sa Salinedda e dal più meridionale degli stagni di Santa Maria.
Descrizione
Situate a circa 20 km a Nord di Guspini, le rovine del sito denominato "Santa Maria di Nabui" si trovano in una pianura alluvionale il cui terreno è stato bonificato per favorire l'impianto di attività agricole che si conducevano nella zona da secoli.
Abitato fin dal Neolitico, divenne sede di uno scalo commerciale già dal Bronzo Finale, per essere poi trasformato in emporio dai Fenici e fondato come città dai Punici di Cartagine. In Età Romana prosegue la vocazione commerciale del centro, strategico per il commercio dei cereali e delle risorse metallifere provenienti dall'entroterra: sono tutt'ora visibili i resti delle strutture abitative, di un acquedotto, di un tracciato viario e delle terme. La continuità di vita del centro abitato è attestata ancora per secoli: nella Cosmografia dell'Anonimo Ravennate Neapolis è citata tra le civitates dell'isola di Sardegna. In particolare, parte dell'edificio termale realizzato con la tecnica dell'opus caementicium e paramento esterno ed interno in opus vittatum mixtum a spigoli murari in laterizio, la cui edificazione si data all'Età Imperiale tarda (II-III sec. d. C.), situato nel settore sud-orientale della città antica, fu riutilizzato sino al secolo XVIII come chiesa intitolata alla Vergine Santa Maria de Nabui. L'edifico di culto cristiano fu realizzato sfruttando uno spazioso ambiente termale a pianta rettangolare, voltato a botte. In occasione di questo intervento, venne tamponata un'ampia apertura rettangolare posta sul lato corto dell'ambiente. La struttura, fortemente danneggiata e che è stata oggetto di recenti interventi di consolidamento e restauro, si conserva in alzato per circa m. 3,1, mentre residuano anche alcune porzioni del pavimento originario. Le pareti interne presentano tracce di intonaco su cui sono ancora visibili graffiti e monogrammi cristologici riconducibili alla frequentazione dell'ambiente come edificio di culto. Allo stato attuale delle ricerche archeologiche, non è dato conoscere con precisione il momento della trasformazione dell'edificio termale in chiesa di culto cristiano: da alcuni confronti con contesti sardi similari, anch'essi oggetto di cambio di destinazione dell'uso termale (Sant'Andrea di Pischinappiu di Narbolia, Santa Maria di Vallermosa, Santa Maria di Mesumundu, santuario di Nostra Signora di Bonacattu a Bonarcado), il passaggio sembrerebbe potersi collocare in epoca altomedievale o in Età Vandalica al più tardi.
La chiesa risulta essere in piena attività fino al XVIII secolo: vi si celebravano ancora i riti cristiani quando venne interdetta da Monsignor Pilo, Vescovo di Ales-Terralba in quanto divenuta rifugio per trafficanti.
Consulta le pagine
Città fenicio-punica di Neapolis
Città romana di Neapolis
Storia degli scavi e degli studi
L'area di Neapolis è nota in letteratura fin da tempi remoti: Plinio il Vecchio, nel I sec. a. C., nel terzo libro della sua Naturalis Historia, elencava tra i popoli e le città della Sardegna romana, diciotto oppida, tra cui alcune civitates stipendiariae abitate da peregrini (Sulci, Valentia, Neapolis, Bitia); è citata come centro costiero da Tolomeo (III, 3, 2), che include la città tra le poleis del litorale occidentale dell'isola di Sardegna; sarebbe inoltre oramai inequivocabile la sua identificazione con il Neapolitanus portus, noto da portolani e carte nautiche del XIII secolo, come pure la menzione di Domo de Neapolis, riferito a un modesto villaggio rurale citato nei documenti verso la metà del XIII secolo sembrerebbe da riferirsi a questo contesto.
L'importanza del contesto archeologico era ben evidente già nel XIX secolo quando Vittorio Angius ne descriveva l'estensione dell'abitato a valenza prevalentemente commerciale e le caratteristiche delle emergenze monumentali.
Le ricerche archeologiche nell'area furono avviate verso la metà del XIX secolo e riprese nel 1951, ma si attivarono in modo intenso e quasi continuativo dagli Anni Settanta del secolo scorso fino a oggi.
Bibliografia
R. Martorelli, Le città in Sardegna fra tardo-antico e altomedioevo, in S. Angiolillo, R. Martorelli, M. Giuman, D. Artizzu, La Sardegna Romana e Altomedievale. Storia e materiali, collana "Corpora delle Antichità della Sardegna", Sassari 2017, pp. 265-278;
E. Usai, M. Casagrande, C. Oppo, L. Garau, A. Loy, P. G. Spanu, R. Zanella, R. Zucca, Il paesaggio del potere cittadino di una città sardo-romana: le "Grandi Terme" di Neapolis, in M. B. C., A. Gavini, A. Ibba (a cura di), L'Africa romana. Trasformazione dei paesaggi del potere nell'Africa settentrionale fino alla fine del mondo antico. Atti del XIX convegno di studio. Sassari, 16-19 dicembre 2010, Roma 2012, pp. 1905-1929;
P. G. Spanu, La Sardegna bizantina tra VI e VII secolo, collana "Mediterraneo tardoantico e medievale. Scavi e ricerche", 12, Oristano 1998, pp. 56-58, 131-143;
P. G. Spanu, L'impianto urbanistico della città romana, in R. Zucca (a cura di), Splendidissima civitas Neapolitanorum, Roma 2005, pp. 245-279;
R. Zucca, Splendidissima civitas Neapolitanorum, Roma 2005;
R. Zucca, Neapolis e il suo territorio, Oristano 1987;
C. Puxeddu, La romanizzazione, in Diocesi di Ales-Usellus Terralba. Aspetti e valori, Cagliari 1975, pp. 165-221;
G. Spano, Descrizione dell'antica Neapolis, in "Bullettino Archeologico Sardo ossia raccolta dei monumenti antichi di ogni genere di tutta l'isola di Sardegna", n. 9, Cagliari 1859, pp. 129-137.
Come arrivare
Si percorre la SS 130 fino al bivio per Villasor e si imbocca la SS 196 che conduce a Guspini. Arrivati alla cittadina, si prende la SS 126 fino al km 94, dove si devia a s. per Sant'Antonio di Santadi. Dal bivio, si percorrono circa 15 km e si devia a d. in una strada di penetrazione agraria. Dopo circa 200 m ci si trova nell'area archeologica.
Actualizar
Dónde está
Imágenes
Textos
Video

Autor : Spadetta Giulio
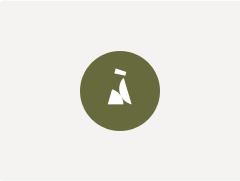
Resultados 2 de 49417
Ver todoAudio
Comentario